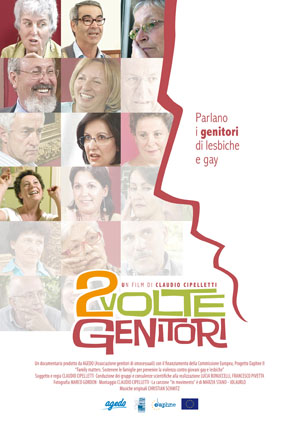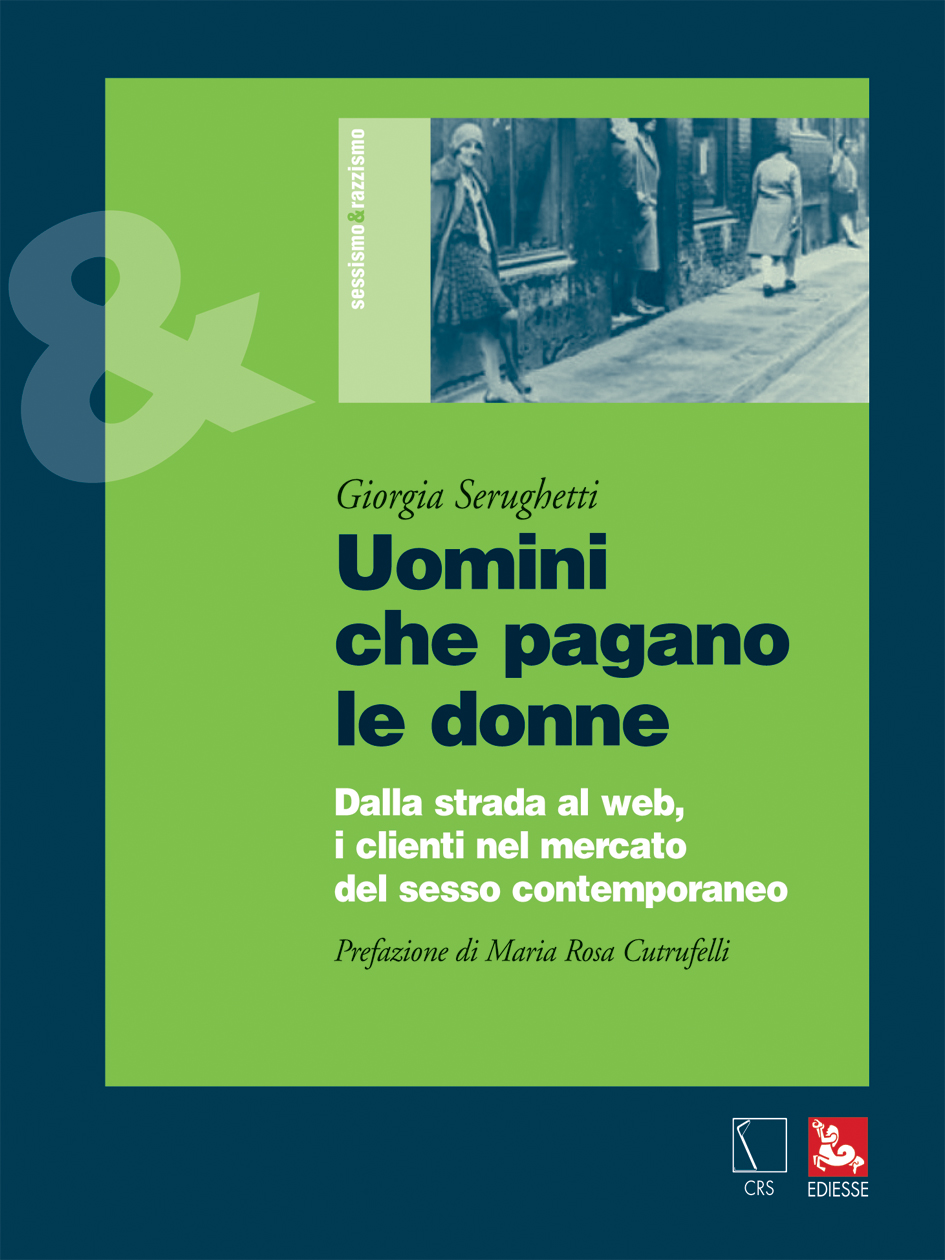pubblicato su femministerie
di Cecilia D’Elia e Giorgia Serughetti
Gli ultimi dati Istat sulla popolazione confermano che siamo un paese che invecchia e si spopola. Lo sappiamo da tempo. In Italia la popolazione continua a diminuire, perché gli stranieri che arrivano sono sempre meno, mentre i giovani che lasciano il paese sono sempre di più. E con loro se ne vanno anche i progetti di genitorialità, già messi duramente alla prova dalle condizioni di vita e dai mutamenti dei costumi. Cosicché non solo il numero dei figli per donna è oggi al minimo storico, ma anche quello delle donne in età fertile. E per ogni 100 residenti che muoiono ne nascono solo 67. Dieci anni fa erano 96. Dobbiamo risalire all’immane tragedia della prima guerra mondiale, al 1918, per trovare un saldo negativo della stessa misura.
Spesso, nel nostro paese, chi ragiona di denatalità, in cerca di soluzioni, finisce per entrare maldestramente nel campo dell’autodeterminazione delle donne, che abbiamo faticosamente conquistato nel corso di decenni. Anche a causa di questa paura, del rischio che ogni discorso sulla fecondità in declino si tramuti in un atto di accusa verso l’autonomia femminile, questo è per noi femministe un tema difficile, quando non un tabù.
Il problema però è serio, da molti punti di vista. E noi vorremmo provare ad affrontarlo, guardando sia alle potenzialità e ai limiti dei punti di vista che si confrontano, sia – soprattutto – a ciò che questa discussione lascia fuori e che resta troppo spesso inesplorato.
Cominciamo col dire che la prospettiva più frequente che troviamo nei commenti è quella dell’insostenibilità economica degli attuali cambiamenti demografici. A questi ritmi, si dice, il Pil andrà calando, la spesa previdenziale andrà aumentando a dismisura, il welfare imploderà, il reddito pro-capite calerà, ecc.
Sono tutte preoccupazioni giuste. A cui però si potrebbe rispondere invocando, per esempio, frontiere più aperte, visto che il problema del declino demografico riguarda noi, ma non il pianeta, dove siamo fin troppi e continuiamo ad aumentare.
Certo, qui si apre un fronte di conflitto con i sovranisti/nativisti, che i figli li vogliono solo di un certo colore, o lingua, o cultura, e paventano il pericolo della “sostituzione dei popoli” causata da politiche migratorie troppo generose. Ma la verità è che l’agitazione di una presunta “emergenza immigrazione” oscura la realtà dell’emigrazione forzata dei nostri giovani.
Se guardiamo a chi lascia il paese, a chi i figli magari li fa, ma non in Italia, viene in primo piano un’altra lettura, molto diversa, della questione demografica, quella basata sui diritti. Da questo punto di vista, i figli che non si fanno raccontano storie di diritti negati, di desideri insoddisfatti a causa della mancanza di lavoro decente, delle disuguaglianze di genere, dell’assenza di garanzie sociali e infrastrutture pubbliche capaci di sostenere le scelte di maternità, i percorsi di genitorialità, inclusi quelli delle madri single o delle coppie omosessuali. In Italia una donna su quattro perde il lavoro con l’arrivo del primo figlio. I servizi per l’infanzia, le politiche di condivisione e gli investimenti sociali sono immensamente fragili. Nell’ultima manovra si sono fatte alcune scelte, con l’introduzione dell’assegno unico, ma siamo davvero ai primi passi.
È giusto quindi denunciare l’assenza di misure di welfare, perché i dati parlano chiaro: nei paesi a sviluppo avanzato la fecondità aumenta con la crescita della parità, del benessere e dell’occupazione femminile. Da questa angolazione, la ripresa della natalità è legata al benessere delle donne, al loro lavoro, come spiega molto bene Roberta Carlini su Ingenere.
C’è però un’altra questione ancora, parzialmente diversa, che sfugge a tutti questi discorsi e che a noi interessa mettere a fuoco.
La scelta personale, in particolare di quelle donne che non desiderano diventare madri, non si discute. Avere figli è però una decisione che riguarda le persone singole ma attiene anche alla dimensione comune del vivere insieme, al modello di società che si costruisce e alla sua percezione del futuro. È insomma una questione politica.
Ieri Michele Serra dedicava la sua Amaca a La fine del proletariato, leggendo la denatatalità come figlia del narcisismo della società dei consumi: “Questa parte del discorso (si fanno meno figli perché siamo, uomini e donne, molto ma molto occupati a vivere per noi stessi) è più sgradevole e dunque più difficile da dire. Faticosa anch’essa. Eppure è un pezzo evidente del problema.” L’articolo non convince per varie ragioni, tra cui il rapporto inverso che stabilisce tra benessere e fecondità, quando invece abbiamo visto che oggi i figli li fa chi vive meglio. Ma coglie un punto a nostro avviso importante: la necessità di andare oltre la sola dimensione privata della questione o le discussioni sulle diverse politiche a sostegno delle famiglie, per guardare più ampiamente a ciò che successo alle nostre relazioni, al nostro stare insieme.
Decenni di discorso neoliberale e di cultura individualista hanno distrutto, nel nostro paese, lo spazio politico delle relazioni tra esseri umani, e ucciso le promesse del futuro. Mentre diventare genitori è esattamente aprirsi al futuro, accettare l’imprevisto che arriva con ogni nascita. È anche una scelta che eccede la logica costi/benefici, come ogni scelta che implica la cura di nuove generazioni, inclusi i figli altrui.
E avere cura, in tutti i sensi possibili, significa esporsi agli altri, alla dipendenza propria e altrui, alla vulnerabilità.
C’è allora, probabilmente, un circolo vizioso che lega l’infelicità politica, le passioni tristi del nostro tempo, e le “culle vuote”. Così come può essere stabilito un circolo virtuoso tra l’impegno politico per la ricostruzione del nostro vivere insieme e il desiderio di mettere al mondo nuovi esseri umani o di attivarsi in vario modo per la cura delle nuove generazioni.
In gioco, cioè, non c’è solo la tenuta dei sistemi di welfare e dell’economia, e non c’è solo il desiderio singolare di chi vorrebbe avere figli e non può. In gioco c’è il futuro di una comunità politica che rischia di esaurire ogni spinta immaginativa, consegnandosi a un orizzonte ristretto, chiuso verso il presente e incapace di pensare il futuro.
Ne va quindi della vita politica, ma nel senso ampio, e radicale, di cura di un mondo comune, in cui ogni nuovo nato è un imprevisto, una possibilità, una breccia nel già noto, nel già dato.
Se è così, però, per affrontare la questione demografica bisogna rovesciare interamente la prospettiva: trasformare quella che appare come una questione che ha a che fare solo con le biografie individuali, o solo con la bilancia dei conti pubblici, in un grande problema politico, che chiama in causa una responsabilità collettiva, e richiede niente di meno che di ricominciare a tessere il filo che lega il presente con il futuro. Una sfida di fronte a cui il protagonismo delle donne, e l’eredità preziosa del pensiero femminista, appaiono più necessari che mai.