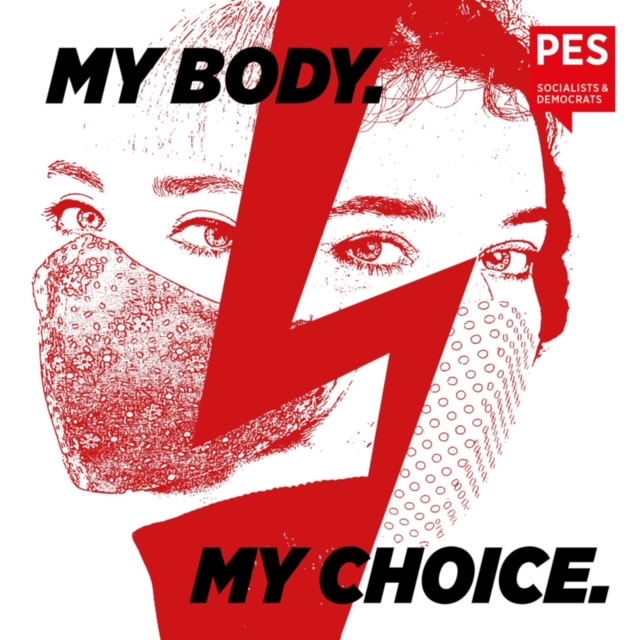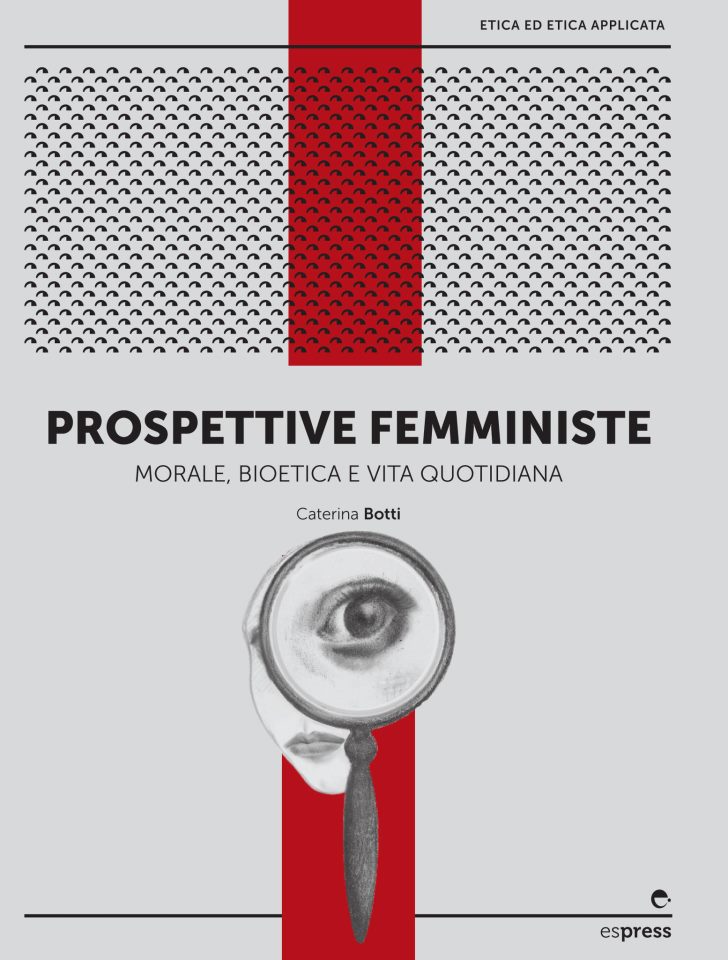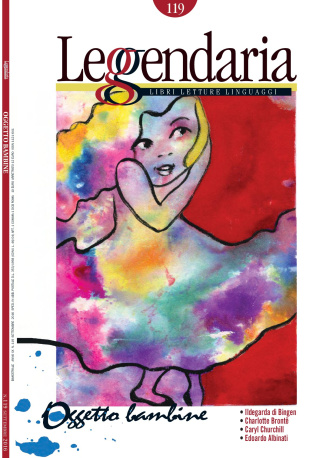da www.italia2013.org
Una volta una persona lavorando migliorava gradualmente le proprie condizioni di vita: comprava la casa, la macchina, andava in vacanza, si curava meglio, cresceva dei figli. Oggi si continuano a fare queste cose, anche se un po’ meno, soprattutto grazie al risparmio della propria famiglia. Uno dei motivi è un particolare aspetto della precarietà quasi sempre dimenticato: non solo il lavoro è saltuario, non solo ci sono periodi anche lunghi senza reddito, non solo quando si viene pagati lo stipendio è molto basso. No, c’è un altro fattore: lo stipendio del precario non aumenta mai, non si adegua neanche lontanamente né all’inflazione reale né a quella programmata. E questo ha un costo, vediamo quant’è e vediamo quanto sono realistiche alcune proposte sul mercato del lavoro di cui si parla molto.
1. L’Istat ha diramato qualche giorno fa i dati provvisori sull’aumento dei prezzi, includendo un indice molto spesso trascurato: l’aumento dei prezzi dei “prodotti acquistati con maggiore frequenza” (qui il file più lungo). E’ una categoria che include i seguenti beni: “oltre ai generi alimentari, le bevande alcoliche e analcoliche, i tabacchi, le spese per l’affitto, i beni non durevoli per la casa, i servizi per la pulizia e manutenzione della casa, i carburanti, i trasporti urbani, i giornali e i periodici, i servizi di ristorazione, le spese di assistenza.” Ebbene, questi prezzi sono aumentati, tra il gennaio del 2011 ed il gennaio 2012 del 4,2%. E poteva andare peggio, se si pensa che a gennaio 2008 i prezzi di questi beni erano aumentati del 5% rispetto ad un anno prima. In termini concreti, vuol dire che un precario o una precaria che spendono per questi beni 10.000 euro l’anno avranno speso, nell’ultimo anno, 420 euro in più pur non avendo avuto alcun aumento di stipendio. Si dirà: ma quel dato non tiene conto della diminuzione dei prezzi di altri beni come i biglietti aerei o l’elettronica che un precario, per quanto a basso reddito, prima o poi comprerà. Guardiamo allora all’indice complessivo: segna +3,2%, cioè il precario di prima avrà speso 320 euro in più all’anno senza averne guadagnato neanche uno in più. Perché è inutile fare più straordinari: al precario arriva sempre lo stesso stipendio, indipendentemente dalle ore lavorate. Per molte e molti si tratta di 15 giorni di lavoro in più all’anno il cui reddito è stato impiegato solo per continuare a mangiare, spostarsi e abitare come l’anno precedente. Senza nessun miglioramento rispetto all’anno precedente, come quei criceti che corrono come pazzi ma la loro gabbia non si sposta mai.
2. Questi dati dovrebbero far riflettere sotto molti aspetti. In primo luogo, come abbiamo già scritto, certe dinamiche salariali hanno compresso la domanda di beni che a sua volta ha compresso la crescita e la creazione di nuovi posti di lavoro. In secondo luogo, i contratti precari non godono di aumenti perché sono fuori dalla contrattazione collettiva: provate voi a chiedere un aumento quando dovete negoziarlo da soli con il vostro datore di lavoro ed in una situazione in cui è già una fortuna avercelo un lavoro. Terzo, come dicevamo all’inizio, salari così bassi e con potere d’acquisto decrescente hanno fatto sì che le grandi spese della vita (casa, macchina, figli tanto per fare tre esempi) dipendano dai risparmi dei genitori. Vanno avanti così solo quelli che hanno genitori provenienti dall’ex-classe media o dal ceto benestante, alla faccia del merito. E’ opportuno dire “ex-classe media” perché queste dinamiche salariali per i precari aiutano anche a spiegare un certo impoverimento che, non a caso, il senso comune fa risalire ai primi anni duemila. Solo che viene attribuito tutto all’Euro e poco allo sganciamento di una quota crescente di salari dalla contrattazione collettiva. Quarto, si dice spesso che bisogna togliere ai garantiti per dare ai non garantiti. In questo caso, quindi, dovrebbe essere vero che i precari non hanno visto aumenti di stipendio perché i “garantiti” dai contratti nazionali si sono accaparrati tutta la torta. I dati mostrano il contrario: anche quelle retribuzioni segnano il passo rispetto all’inflazione. E’ vero invece che il precariato è andato di pari passo con un grande trasferimento di risorse dal lavoro verso le rendite ed i profitti per i quali non c’è stata alcuna “politica dei redditi”.
3. Infine, è opportuno segnalare l’intervista a Luciano Gallino su Rassegna.it per due cose. La prima è la misurazione del calo della cosiddetta “flessibilità in uscita” che secondo Gallino è aumentata dal 3,57 del 1996 all’1,89 del 2008 (più basso è il numero, maggiore la flessibilità). L’Italia è già oggi molto più flessibile della Germania, eppure lì l’occupazione soffre molto meno della crisi. Merito di una bilancia commerciale più favorevole e di un migliore stato sociale, certo, ma Gallino spiega anche che nelle grandi aziende tedesche è stato possibile ridurre l’orario di lavoro riducendo molto poco lo stipendio grazie ad aiuti statali e delle imprese e salvando tutti i posti di lavoro. Spiega anche che gli investimenti in ricerca e sviluppo della Volskwagen sono dieci volte quelli delle Fiat. Chi è appassionato di macchine se n’è accorto da un po’. La seconda cosa importante dell’intervista è la critica del cosiddetto “modello danese” della “flexicurity” molto spesso citata come obiettivo dai sostenitori italiani di una maggiore “flessibilità in uscita”. Gallino dice che la disoccupazione danese, se si contassero anche i lavoratori pre-pensionati o parcheggiati in corsi di formazione sarebbe al 15%. Da poi un dato che dovrebbe far riflettere: “L’estrema flessibilità del mercato del lavoro danese porta ogni anno il 30 per cento degli occupati a cambiare lavoro, anche spostandosi. Ma la Danimarca è piccola: pensi all’impatto che potrebbe avere in Italia se il 30 per cento degli occupati (cioè 6 milioni di persone) dovessero ogni anno spostarsi per una penisola lunga duemila chilometri.” Aggiungiamo noi: pensate a 6 milioni di italiani che si spostano ogni anno dovendo barcamenarsi in un mercato degli affitti allucinante e spostando di volta in volta i figli. Tanto gli asili nido funzionano a Torino come a Catania no?
Eppure, questa componente del “modello danese” c’è già: centinaia di migliaia di italiani si spostano ogni altro e lasciano il sud. Ma di questo ne parleremo nei prossimi giorni.
(Mattia Toaldo, con la preziosa collaborazione di Mara Gasbarrone, Lorenzo Cassata e Alfredo Amodeo)